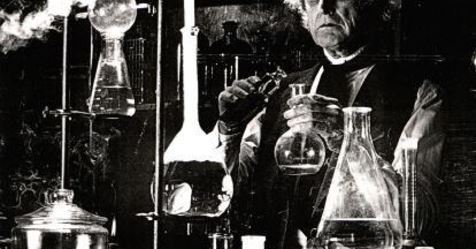Sabine Hossenfelder dice la sua su come "raccontare" l'entropia:
Sabine Hossenfelder dice la sua su come "raccontare" l'entropia:"Davvero l'idea che l'entropia misuri il disordine non è per niente d'aiuto. Supponiamo che io prepari un impasto, che io rompa un uovo e lo faccia cadere sulla farina. Aggiungo zucchero e burro e mescolo finché l'impasto non è omogeneo. Quale stato è più ordinato, l'uovo rotto sulla farina con sopra il burro o l'impasto finale? Direi l'impasto. Ma quello è lo stato a più alta entropia....
L'entropia è definita come il numero di microstati che danno lo stesso macrostato. I microstati contengono tutti i dettagli dei componenti individuali di un sistema. Il macrostato invece è caratterizzato solo da informazioni generali, come "separato in due strati" o "mediamente omogeneo". Ci sono molti stati per gli ingredienti dell'impasto che daranno l'impasto quando mescolati, ma assai pochi stati che separeranno uova e farina quando mescolate. Quindi l'impasto è a più alta entropia..."
Questa definizione di entropia è mutuata dalla termodinamica statistica, uno strumento potente i cui risultati convergono su quelli della termodinamica classica. Si tratta di modelli, e ognuno dei due è più utile e maneggevole dell'altro, a seconda della situazione.
La prima cosa che faccio notare è che quando si parla di entropia come misura del disordine la definizione muta a seconda del concetto di disordine che possediamo. Agli occhi di un chimico è immediato che l'impasto sia lo stato a più alta entropia.
La seconda cosa che faccio notare è che lo stato a più alta entropia è in questo caso il risultato di un processo non spontaneo. Parafrasando Hossenfelder, sono pochissimi gli stati che portano spontaneamente a impasto da uovo rotto più farina (pochissimi vuol dire di fatto 0, ma stiamo parlando di termodinamica statistica, e quindi il concetto di "stato impossibile" va maneggiato con cautela, mentre è più comune quello di "stato improbabile").
Comunque il risultato del processo di mescolamento è l'impasto e il processo, in questo caso, è irreversibile.
Ma facciamo un altro esempio: uova e olio. In questo caso il prodotto a più alta entropia è la maionese. Ma la probabilità di ottenimento della maionese alla fine del processo non è particolarmente alta, e di sicuro non è alta quanto quella dell'impasto. La maionese può "impazzire", ovvero dare un sistema a due fasi parzialmente mischiate, a entropia più bassa rispetto alla maionese.
E quindi è il percorso, il processo, il fenomeno che diventa cruciale: l'entropia finale non guida la trasformazione (non costituisce la "driving force" del processo) - cosa è che gioca nell'ottimento della maionese (che è una particolare emulsione)? Una quantità di fattori, sforzo di taglio dell'agitazione, forza ionica delle fasi acquose (l'uovo), carica elettrostatica.
https://backreaction.blogspot.com/2018/07/10-physics-facts-you-should-have.html?m=1